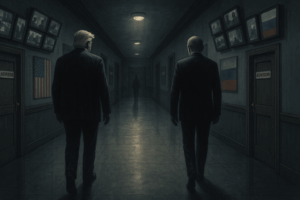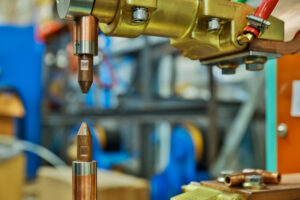Adolescenti e social media: come TikTok e Instagram stanno influenzando l’autostima

Adolescenti e social media: come TikTok e Instagram stanno influenzando l’autostima
Scorrono veloci, colorate, coinvolgenti. Le immagini e i video che popolano i social media come TikTok e Instagram sono parte integrante della quotidianità degli adolescenti. Per la generazione Z, quella nata tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2010, queste piattaforme non sono solo uno strumento di intrattenimento, ma un vero e proprio specchio sociale. Un luogo in cui il valore personale sembra misurarsi in like, visualizzazioni, commenti e follower.
Tuttavia, dietro l’apparente leggerezza di balletti virali e selfie patinati, si nasconde una realtà più complessa e preoccupante. Gli esperti avvertono che l’esposizione continua a contenuti idealizzati può avere effetti negativi sulla salute mentale degli adolescenti, incidendo in modo significativo sull’autostima.
Paragoni sociali, standard estetici irrealistici, ricerca spasmodica di approvazione: sono tutti elementi che, quando vissuti senza filtri critici, possono portare a sentimenti di inadeguatezza, ansia, disturbi alimentari e persino depressione.
Uno studio recente pubblicato su JAMA Pediatrics ha evidenziato che gli adolescenti che trascorrono più di tre ore al giorno sui social hanno maggiori probabilità di sviluppare sintomi legati alla salute mentale, rispetto a chi ne fa un uso più moderato.
Il dato fa riflettere, soprattutto se si considera che, secondo una ricerca dell’ISTAT, in Italia l’88% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni utilizza regolarmente piattaforme social, con una media di oltre 4 ore al giorno.
In questo contesto, educatori, genitori e psicologi si interrogano su come affrontare una sfida tanto urgente quanto invisibile: quella di proteggere l’autostima degli adolescenti in un mondo digitale che corre veloce e spesso non perdona. Perché l’autostima non è un like.
L’identità riflessa nello schermo: quando il numero di follower vale più di uno specchio
L’adolescenza è per definizione un periodo di costruzione dell’identità. È l’età in cui ci si sperimenta, si cercano riferimenti, si mettono alla prova limiti e confini. È anche l’età in cui il giudizio altrui assume un peso enorme, spesso superiore a quello del proprio giudizio interno.
In un tempo non così lontano, questo avveniva nel cortile della scuola, tra amici o compagni di classe. Oggi, accade su TikTok, su Instagram, tra filtri, commenti e scroll infiniti.
L’esposizione costante all’approvazione (o disapprovazione) pubblica può diventare un’arma a doppio taglio. Il numero di like, le visualizzazioni ottenute da un video, il numero di follower: tutto questo viene interiorizzato come parametro del proprio valore.
Se un contenuto non “funziona”, il messaggio che passa può essere: “non valgo abbastanza”. Un meccanismo tossico che, giorno dopo giorno, può minare profondamente la fiducia in sé stessi.
Il confronto è inevitabile e, quasi sempre, impari. Sui social si tende a mostrare solo il lato perfetto della propria vita: il corpo scolpito, la vacanza da sogno, il viso filtrato, la felicità ostentata. Eppure, dietro quelle immagini, spesso ci sono ritocchi, regie precise, momenti selezionati.
Il problema è che il cervello adolescente fatica a distinguere ciò che è costruito da ciò che è autentico. Il risultato? Un senso di inferiorità che si alimenta ogni giorno, e che può avere conseguenze molto serie.
Numerosi studi hanno evidenziato una correlazione tra l’uso intensivo di social media e l’insorgenza di disturbi dell’umore, disturbi alimentari e depressione tra i più giovani. Il report “Digital 2023” curato da We Are Social e Hootsuite ha segnalato che una percentuale crescente di adolescenti riferisce di sentirsi “inadeguata” o “infelice” dopo aver navigato sui social.
Questo dato trova conferma anche nei colloqui psicologici: i giovani raccontano di sentirsi sempre “indietro” rispetto agli altri, di non essere mai abbastanza belli, interessanti o amati.
Anche il linguaggio del corpo cambia. Sempre più ragazzi chiedono interventi estetici in giovane età, spinti da ideali irraggiungibili imposti da influencer e celebrity digitali. La cosiddetta “dismorfia da Snapchat” – la tendenza a desiderare nella realtà il proprio aspetto filtrato – è oggi riconosciuta come disturbo psicologico emergente.
Ma se il problema nasce nel digitale, è proprio nel mondo reale che si possono trovare le risposte.
Educare alla consapevolezza digitale: la nuova sfida di genitori e scuole
Fortunatamente, la consapevolezza intorno a questi temi sta crescendo. Sempre più psicologi, pedagogisti e insegnanti sottolineano l’urgenza di educare i giovani all’uso critico dei social media. Un’educazione che deve iniziare presto e che non può limitarsi a dire “stai meno al telefono”, ma deve insegnare a interpretare, selezionare, capire ciò che si vede online.
La prima sfida è aiutare i ragazzi a distinguere tra realtà e finzione. Capire che ciò che appare perfetto su uno schermo spesso non corrisponde alla vita vera. Promuovere modelli di bellezza diversificati, valorizzare l’unicità, sostenere l’autenticità: sono questi i messaggi che devono emergere. E non solo da parte di psicologi ed educatori, ma anche delle stesse piattaforme.
Instagram, per esempio, ha iniziato a nascondere il numero di like in alcuni Paesi, per ridurre la pressione sociale. TikTok ha introdotto strumenti di controllo del tempo e contenuti educativi per sensibilizzare gli utenti più giovani. Ma sono solo primi passi. Servono politiche più coraggiose e una maggiore collaborazione tra istituzioni, piattaforme tecnologiche e mondo scolastico.
In alcune scuole italiane sono già attivi corsi di “educazione digitale emotiva”, in cui si lavora sull’empatia, sull’autostima e sulla gestione delle emozioni online. Gli studenti imparano a riconoscere le emozioni scatenate dai social, a non cadere nel tranello del paragone costante, a parlare apertamente del proprio vissuto digitale. In molte classi si introducono laboratori pratici: si analizzano post, si parla di filtri, si costruiscono contenuti positivi.
Anche il ruolo della famiglia è fondamentale. I genitori devono imparare a non demonizzare i social – altrimenti si rischia di creare un muro – ma ad affiancare i figli nel loro percorso digitale. Parlare, ascoltare, osservare: sono queste le chiavi. Mostrare interesse per ciò che i ragazzi pubblicano, aiutarli a gestire i momenti di frustrazione, insegnare che l’approvazione degli altri non definisce il proprio valore.
Infine, i ragazzi stessi devono essere protagonisti del cambiamento. Sono loro i primi a potersi ribellare agli standard tossici, a promuovere contenuti autentici, a scegliere di seguire account che fanno sentire bene, anziché peggio. Sono loro che possono cambiare il volto dei social, un like alla volta.
Conclusione
I social media non sono nemici da combattere, ma strumenti da conoscere, comprendere e usare con consapevolezza. Per la generazione Z rappresentano un mezzo di comunicazione, di espressione, di relazione. Ma quando diventano un’ossessione, un metro di giudizio, un riflesso distorto del proprio valore, allora è necessario intervenire.
L’autostima degli adolescenti è un terreno fragile e prezioso, che va protetto con attenzione e cura. È una responsabilità collettiva: delle famiglie, che devono essere presenti e informate; delle scuole, che devono educare alla cittadinanza digitale; delle piattaforme, che devono assumersi il ruolo sociale che ormai ricoprono; e degli stessi ragazzi, che devono imparare a guardarsi dentro più che sullo schermo.
Perché il valore di una persona non si misura in cuoricini rossi o visualizzazioni. E perché, alla fine, ciò che conta davvero non è chi ci guarda, ma come ci vediamo noi.